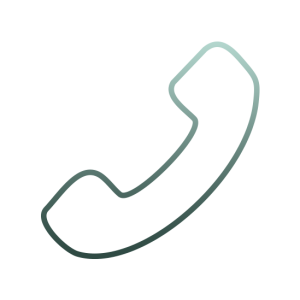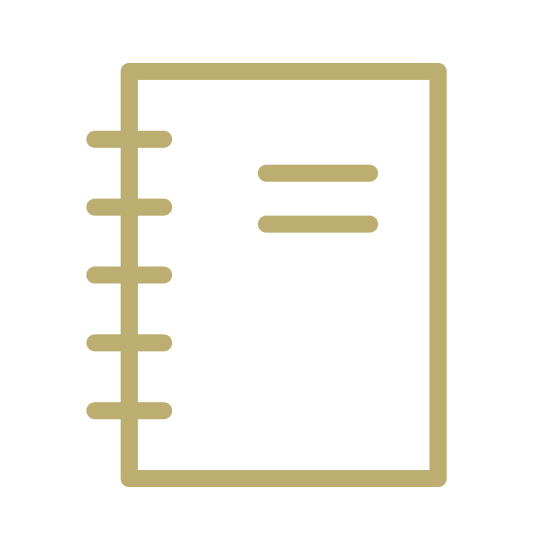
Numero 23
«Fragilità». II. Accoglienza e cura
Gennaio - Dicembre 2007
Abstract e allegati
di Giovanni GirardiFull Text
Una seconda serie di contributi completa la riflessione già avviata nel precedente numero di Esperienza e Teologia, anch’esso dedicato al tema della “fragilità”.
di Gianattilio BonifacioFull Text
Abstract
The redeemed frailty
Marco gives to the character of Pietro large prominence and guarantees him an important communicative role in the Second Gospel. With James, John and Andrew and as spokesman of the Twelve Apostles, he becomes more important both than the biggest group and the smaller one. As the story goes on, Jesus himself, interacting with Pietro, progressively shapes the character who becomes for the readers the reference disciple figure. We find this narrative device in the Passion Stories too and right here it achieves its best expressive power. The comparison between the Jesus’ firmness and the Pietro’s conceited poltroonery unforgiving deconstructs the character. Only the risen Christ will be able to reconstruct him in his disciple and group spokesmen identity. Pietro becomes the “first” because, actually, it was the “last”.
Sommario
Marco riserva ampio rilievo al personaggio di Pietro e gli garantisce un importate ruolo nell’impianto comunicativo del II vangelo. In quanto portavoce dei Dodici/discepoli, egli viene spesso messo in risalto sia rispetto al gruppo più ampio, sia rispetto a quello più ristretto, con Giacomo, Giovanni e Andrea. Mano a mano che si dipana il racconto, Gesù stesso, interagendo con Pietro, ne modella progressivamente il personaggio che così diventa – per il lettore – la figura discepolare di riferimento. Questo dispositivo narrativo non viene meno nei racconti della Passione. Anzi proprio lì raggiunge la sua massima forza espressiva. Il confronto tra la fermezza di Gesù e la boriosa pavidità di Pietro ne decostruisce impietosamente il personaggio. Solo il Risorto lo saprà ricostruire nella sua identità di discepolo e portavoce del gruppo. Pietro viene costituito come il “primo”, perché, fino in fondo, è stato “ultimo”.
di Serena NocetiFull Text
Abstract
Living the Church frailty
The individuation of the ecclesial life’s frailties and its reasons, benefits from the convergence of the complementary prospective: the combination to the reality of the Church through the new Testament metaphors (buildings, home, temple, body,…) and the interpretation of the church phenomenon in the historical context. In research emerge tree levels of frailty: the one bounded to the today’s cultural context, the one related to the resistance to the call to be church in fullness and the other that looks at the frailty as a chance for a new face of the Church. The challenge of the Church doesn’t cancel the necessity of the ecclesiastical institution, but demand a “church frail figure", which, without dissolving and shattering (" fragile church "), could come about in the logic expressed by the cross and the Jesus resurrection. The purpose is the task of creating adult consciousness, in the accepting of the challenge regarding the faithfully-protect the identity in a serious relationship with the history emerging, in the courage of choosing a “poor” pastoral style (LG 8). It is so possible to live in a eschatological way a “fragile form” of the Church, while we take part to its construction and we glimpse its future form.
Sommario
L’individuazione delle fragilità presenti nella vita ecclesiale e delle ragioni ad esse sottese si giova della convergenza di due prospettive complementari: l’accostamento alla realtà della chiesa attraverso le metafore neotestamentarie (edificio, casa, tempio, corpo,…) e l’interpretazione del fenomeno chiesa nel suo darsi storico. Emergono dall’indagine tre livelli della fragilità: quello legato al contesto culturale odierno, quello della resistenza alla chiamata a essere chiesa in pienezza, quello che guarda alla fragilità come chance per un nuovo volto di chiesa. La sfida della fragilità non annulla la necessità dell’istituzione ecclesiale, ma domanda una “figura fragile” di chiesa, che, senza dissolversi e frantumarsi (“chiesa fragile”), si realizzi nella logica espressa dalla croce e risurrezione di Gesù. L’obiettivo intravisto si traduce nell’assunzione del compito di formare delle coscienze adulte, nell’accettazione della sfida di custodire fedelmente l’identità in rapporto serio col divenire della storia, nel coraggio di optare per uno stile pastorale “povero” (LG 8). Sarà così possibile abitare già escatologicamente una “forma fragile” di chiesa, mentre si partecipa alla sua costruzione e se ne intravede la forma futura.
di Sergio GaburroFull Text
Abstract
The treasure in the clay’s frailty
From the awareness that «numerous divisions within Christianity spring in the conflicts of texts interpretation, symbols and practices of the Christian faith» the contribution to ecumenical reflection about the hermeneutics comes to life with the title: treasure in earthen vessels, of the Ecumenic Council of Churches, “Faith and Constitution” (ECC). There are three prospectives. Firstly it affirms that an ecumenical hermeneutic can’t use only exegetical instruments and methods isolating itself from the richness of an experience in the community that interprets the Scripture and indicating a common interpretation (traditions) of the unique Tradition (Jesus reborn). Secondly, precisely because the biblical texts are born in concrete historical situations, they prove the salvific presence of God the Trinity in those particular circumstances, in the frailty of an earthen vessel, beyond appearances that seem to contradict it. Finally we underline that the common study of the Scripture played a unique role in the formation, in the Christian practice and in the ecumenical journey.
Sommario
Dalla consapevolezza che «numerose divisioni all’interno del cristianesimo hanno la loro origine nei conflitti di interpretazione dei testi, dei simboli e delle pratiche della fede cristiana» prende il via il contributo ad una riflessione ecumenica sull’ermeneutica dal titolo Un tesoro in vasi d’argilla, della Commissione Fede e costituzione del Consiglio ecumenico delle Chiese (CEC). Tre sono le prospettive indicate. In primo luogo si afferma che un’ermeneutica ecumenica non si può limitare all’uso di strumenti e di metodi esegetici isolandosi dalla ricchezza dell’esperienza della comunità che interpreta la Scrittura e indicando lo spazio di un’interpretazione comune (tradizioni) dell’unica Tradizione (Cristo risorto). In secondo luogo proprio perché i testi biblici sono nati in situazioni storiche concrete essi testimoniano la presenza salvifica del Dio Trinità in quelle circostanze particolari, nella fragilità di un vaso di terra, dietro apparenze che sembrano smentirla. Infine si evidenzia che lo studio in comune della Scrittura ha giocato un ruolo unico nella formazione, nella pratica cristiana e nel cammino ecumenico.
di Cristina FrescuraFull Text
Abstract
Job, the story of human frailty
The story of Job, in which the Bible condensed the deepest questions about the frailty of the human condition, has never ceased to provoke relectures in the theological, philosophic and literal field. The stereotype of “patient Job” was certainly called into question, especially in the modern era e in particular thanks to a more careful consideration of the Jewish reading’s tradition of the Bible. Two narrative rewritings collected in the European literature between late 1800s and early 1900s let us set up a comparative path that focuses on the limit issue: this issue has a privileged position thanks to the frailty experience and receives a possible suggestive answer in a reflection-provocation of Élie Wiesel.
Sommario
La vicenda di Giobbe, in cui la Bibbia condensa gli interrogativi più profondi sulla fragilità della condizione umana, non ha mai cessato di provocare riletture in ambito teologico, filosofico, letterario. Lo stereotipo del “Giobbe paziente” è stato messo decisamente in discussione, soprattutto in epoca contemporanea e in modo particolare grazie a una più attenta considerazione della tradizione di lettura ebraica del testo biblico. Due riscritture narrative raccolte nella letteratura europea tra la fine dell’Ottocento e il Novecento permettono di tracciare un breve percorso comparativo, che si focalizza sul rapporto con la questione del limite: questione che l’esperienza della fragilità pone in maniera privilegiata e che trova in una riflessione-provocazione di Élie Wiesel una possibile, suggestiva risposta.
di Eliana ZanolettiFull Text
Abstract
Frail generations? An educational contribution
The articles analyses the frailty in an educational prospective and then characterized by the hope of the possibilities in the young generations. After problematizing the meaning of the word frailty the author argues that the young generations are frail “a priori” because of the evolutionary task they have, that is the construction of their identity. The educational task brings to life the contradictions affecting the adult world. And nonetheless in the recognition of one’s own limits there is place for educating to a responsible frailty, to a reception of our partiality that isn’t only renunciation to our complexity and reductions of expectations.
Sommario
L’articolo affronta il tema della fragilità in una prospettiva educativa e quindi connotata da speranza circa le possibilità insite nelle giovani generazioni. Dopo aver problematizzato il senso del termine fragilità, l’A. sostiene che le generazioni giovanili siano a priori fragili per il compito evolutivo di cui sono investite, ovvero la costruzione della propria identità. Tale fragilità è accentuata dalle condizioni contestuali in cui questo compito viene espletato. Il compito educativo mette in luce le contraddizioni di cui il mondo adulto soffre. E tuttavia, nel riconoscimento dei propri limiti, si apre lo spazio per educare ad una fragilità responsabile, ad un’accoglienza della propria parzialità che non sia semplicemente rinuncia alla propria complessità e riduzione di aspettative.
di Marilena PagiatoFull Text
Abstract
Relations affected by "bullying"
The phenomenon of bullying doesn’t need to be described since the information is abundant and very frequent. Moreover, there are a lot of people who have witnessed or suffered from bullying. Therefore, the following article doesn’t aim to describe the fact, but to analyse causes and reasons which partly justify not adequate conducts. The objective underlying this work is the awareness that an assertive relational style can be learned. Such knowledge justifies and supports the educational/formative effort so that the person can acquire a constructive relationship style in which differences are accepted, the personal skills serve the community, any potential conflicts managed in terms of the negotiations and the personal interests related with the interests of everyone. This formative process can reduce the number of inappropriate behaviours to leave room for the constructive ones.
Sommario
Il fenomeno del bullismo non ha bisogno di essere descritto poiché l’informazione è copiosa e assai frequente. Inoltre, sono numerosi coloro che hanno assistito o subito comportamenti connotati dal bullismo. Il seguente articolo perciò non si propone di descrivere il fatto, ma di analizzare le cause e le motivazioni che in parte giustificano una condotta non adeguata. L’obiettivo sotteso a questo lavoro è la consapevolezza che uno stile relazionale assertivo si può apprendere. Tale conoscenza giustifica e sostiene l’impegno educativo/formativo affinché la persona possa acquisire uno stile relazione costruttivo all’interno del quale le differenze vengono accolte, le competenze personali poste a servizio della comunità, gli eventuali conflitti gestiti in termini negoziali e gli interessi personali messi in rapporto con gli interessi di tutti. Questo cammino formativo potrà ridurre il numero di comportamenti inadeguati per lasciare spazio a quelli costruttivi.
di Ezio FalavegnaFull Text
Abstract
Church development and vitality
The article highlights the original intuition and the modernity of the Juan González Arintero’s (186-1928) ecclesiological reflection, contained in the four copious volumes of Desenvolvimento vitalidad y de la Iglesia. This work mainly consists of the renewal that involve the cultural and religious Spanish environment, of which Arintero is recognized as a leading figure. Among the contributions that helped Arintero reaching such a processing, stand out the historical-critical and exegetical studies, such as those offered by Lagrange; the Möhler, Newman and last but not the least Grea influences; the contribution of natural sciences, study of philosophy and theology, of the Scripture’s deep study, the Fathers and the Church's history. The idea of a Church evolution, which has profoundly influenced the ecclesiological thinking in Arintero, then results in development, vitality and dynamism that guiding the Church to the Kingdom fruitfulness, including through the plausibility of the biblical and patristic images thanks to which the Church has understood herself.
Sommario
L’articolo evidenzia l’intuizione originaria e l’attualità della riflessione ecclesiologica di Juan González Arintero (1860-1928), contenuta nei quattro copiosi volumi di Desenvolvimiento y vitalidad de la Iglesia. Tale opera si comprende soprattutto nella linea del rinnovamento che coinvolge l’ambiente culturale e religioso spagnolo, di cui Arintero è riconosciuto come una figura eminente. Tra gli apporti che hanno aiutato Arintero a una tale elaborazione spiccano gli studi storico-critici ed esegetici, come quelli offerti da Lagrange; gli influssi di Möhler, di Newman e non da ultimo quello di Gréa; l’apporto delle scienze naturali, dello studio della filosofia e della teologia, lo studio profondo della Scrittura, dei Padri, della storia della Chiesa. L’idea di una evoluzione della Chiesa, che ha profondamente influenzato il pensiero ecclesiologico in Arintero, traduce poi, anche attraverso la plausibilità delle immagini bibliche e patristiche con le quali la Chiesa ha compreso se stessa, lo sviluppo, la vitalità e il dinamismo che orientano la Chiesa alla fruttuosità del Regno.
Numeri precedentiVedi tutti

Salvati per Gesù, morto e risorto
Vai al sommario

Divenire Chiesa: soggetti e comunità
Vai al sommario

La Parola di Dio nelle parole umane. Contributi degli studenti
Vai al sommario

Ascoltare e proporre il Vangelo con i giovani
Vai al sommario