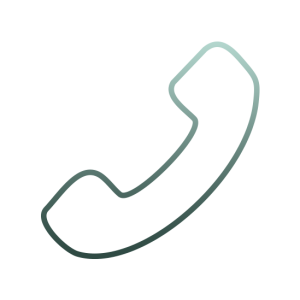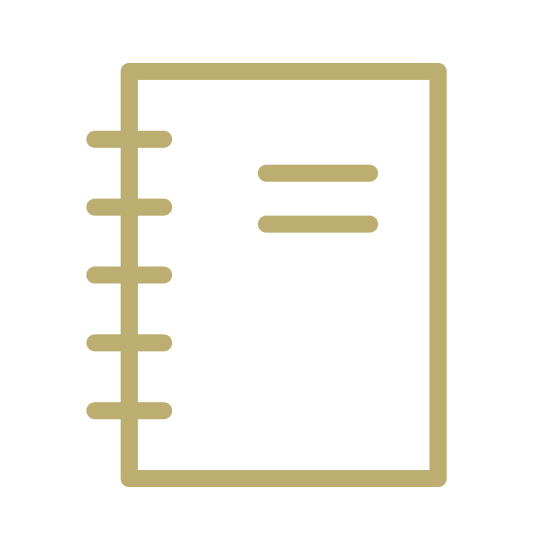
Numero 22
«Fragilità». I. Debolezza e riscatto
Gennaio - Dicembre 2006
Abstract e allegati
di Giovanni GirardiFull Text
Con il presente numero, Esperienza e Teologia assume cadenza annuale.
Il fascicolo, insieme con il successivo che ne proseguirà lo sviluppo, è dedicato alla ripresa di un ambito tematico esaminato nel Convegno Ecclesiale di Verona (16-20 ottobre 2006), quello della “fragilità”. L’abitudine diffusa nel nostro tempo a consumare eventi senza capitalizzare l’esperienza ci suggerisce l’importanza e l’urgenza di non lasciar cadere momenti significativi della vita di Chiesa, contribuendo alla loro recezione anche attraverso il servizio del pensiero della fede, che è la teologia.
di Mario BizzottoFull Text
Abstract
Man: a frail individual
Man’s frailty is rooted in being, then it unfolds in the everyday experience. There is no thinker who hasn’t talked about it without hiding his own confusion and, at the same time, recognizing it as a particularly favourable opportunity for a human maturation process. The frailty then, per se expression of a deficiency, is reversed in a positive sense. Well renowned is the statement that defines the man as a "sick being", explaining further that "sick and weak people are more human, have more spirit." Similarly Nietzsche, rethought then by Th. Mann, who speaks of a "brilliant principle" of the sickness. The reactions to the experience of frailty are as many as there are individuals. There are people seeing in the vicissitudes of life an unavoidable necessity, facing which we can do nothing but resign ourselves passively, and on the other hand there are people who tempt fate in a heroic gesture or, at least, try to save their own souls’ impassivity facing the ruin. In each case, without the leap into transcendence, one always comes out as a victim. There are no remedies to human frailty, but one: faith’s answer.
Sommario
La fragilità dell’uomo affonda le sue radici nell’essere, si esplicita poi nell’esperienza quotidiana. Non c’è pensatore che non ne abbia parlato senza nascondere il proprio sconcerto e nel contempo riconoscendovi un’opportunità particolarmente favorevole per un processo di maturazione umana. La fragilità allora, di per sé espressione d’una carenza, si rovescia in un’accezione positiva. È nota l’affermazione che definisce l’uomo un “essere malato”, chiarendo ulteriormente che “i malati e i deboli sono più umani, hanno più spirito”. Così Nietzsche, ripensato poi da Th. Mann, che parla d’un “principio geniale” della malattia. Le reazioni all’esperienza della fragilità sono tante quanti sono gli individui. C’è chi ravvisa nelle alterne vicende della vita una necessità ineluttabile, di fronte alla quale non resta che rassegnarsi passivamente, chi al contrario sfida il destino in gesto eroico o tenta di salvare davanti al naufragio l’imperturbabilità dell’animo. In ogni caso senza il salto nella trascendenza si esce sempre come vittime. Alla fragilità umana non resta che un solo rimedio: la risposta della fede.
di Nicoletta CapozzaFull Text
"To gaze upon the God of the Bible..."
"Human religiosity defers the man in his own tribulation to the power of God in the world, God is the deus ex machina. The Bible pushes the human being back to the powerlessness and the suffering of God; only the suffering God can help. In this sense we can say that the described evolution towards a greater age of the world, whereby one gets rid of a false image of God, opens a gaze to the God of the Bible, which gets power and space in the world thanks to its powerlessness". So writes Bonhoeffer to his friend Bethge in July 1944 from the prison of Tegel. The German theologian connects the biblical face of a suffering God to the "path of the world towards a greater age", towards emancipation, towards autonomy from a guardian God, a stopgap God, a deus ex machina. It is one of the most interesting incentives which Bonhoeffer leaves as a legacy to the forthcoming theological reflection: to think about modernity and all of the criticism against religion contained in it as a process of purification of God’s idea rather than as a danger and a temptation. And maybe even something more: the rediscovery of the biblical God's face may also contain the seeds for a rethinking of the same categories of power/powerlessness, strength/weakness, fullness/fragility; this because the biblical revelation shows us how the real power really displays himself in powerlessness, the real strength is given in weakness and the fullness of life is reached through fragility. So, what does this "scandal" mean (1 Cor 1,18-25)? How it has provoked and provokes Western thought? And especially, how does it as it cross with contemporary philosophy, which is par excellence a philosophy of crisis (crisis of metaphysics, ontology, ethics, aesthetics ...)? This article, without demanding completeness, wants to propose a reading track which, collecting all of Bonhoeffer’s provocations of Bonhoeffer, may reread the Western logos crisis in the light of re-thinking the suffering face of the biblical God's face.
Sommario
«La religiosità umana rinvia l’uomo nella sua tribolazione alla potenza di Dio nel mondo, Dio è il deus ex machina. La Bibbia rinvia l’uomo all’impotenza e alla sofferenza di Dio; solo il Dio sofferente può aiutare. In questo senso si può dire che la descritta evoluzione verso la maggiore età del mondo, con la quale si fa piazza pulita di una falsa immagine di Dio, apra lo sguardo verso il Dio della Bibbia, che ottiene potenza e spazio nel mondo grazie alla sua impotenza». Così scrive Bonhoeffer all’amico Bethge nel luglio del 1944 dal carcere di Tegel. Il teologo tedesco collega il volto biblico del Dio sofferente al «cammino del mondo verso la maggiore età», verso l’emancipazione, verso l’autonomia nei confronti del Dio tutore, del Dio tappabuchi, del deus ex machina. Si tratta di uno degli stimoli più interessanti che Bonhoeffer lascia in eredità alla riflessione teologica successiva: pensare la modernità e tutta la critica alla religione in essa contenuta come un processo di purificazione dell’idea di Dio piuttosto che come un pericolo e una tentazione. E forse anche qualcosa di più: la riscoperta del volto biblico di Dio può contenere anche il germe per un ripensamento delle stesse categorie di potenza/impotenza, di forza/debolezza, di pienezza/fragilità, perché la rivelazione biblica ci mostra come la vera potenza si manifesti proprio nell’impotenza, la vera forza si dia nella debolezza e la pienezza della vita si raggiunga attraverso la fragilità. Cosa significa questo «scandalo» (1Cor 1,18-25)? In che modo esso ha provocato e provoca il pensiero occidentale? E soprattutto come esso si incrocia con la filosofia contemporanea, che è per eccellenza filosofia della crisi (crisi della metafisica, dell’ontologia, dell’etica, dell’estetica...)? L’articolo, ben lungi da qualsiasi pretesa di completezza, vuole proporre una pista di lettura che, raccogliendo le provocazioni di Bonhoeffer, rilegga la crisi del logos occidentale alla luce del ripensamento del volto sofferente del Dio biblico.
di Martino SignorettoFull Text
Abstract
«Show me the way … and I’ll know how fagile I am»
The frailty inside the Sacred Scriptures is only recognizable if we comprehend the mystery of poverty or, indeed, the mystery of the poor people in the Bible. They are identified in various ways and as a consequence the frailty shows up in different forms, becoming a fundamental boundary, a threshold that only a powerful hand, an intervention from above can overstep. From this situation, this threshold springs the “scream” and the “protest”, which we oft find in the psalms as a specific literal genre; an unusual way of speaking to God. The psalm 39, in the psalter context, places the prayer’s frailty in the salvific and wisdom historical trajectory. The frailty is identified by a “creative observatory”, from an unhoped-for point of view that is able to open heart and mind to unpredictable light ways.
Sommario
La fragilità nelle Scritture è riconoscibile se penetriamo il mistero della povertà, anzi, dei poveri nella Bibbia. I poveri sono identificati in vari modi, di conseguenza la fragilità si presenta sotto varie forme, diventando limite invalicabile, una soglia che solo una mano potente, un intervento dall’alto può far valicare. Da questa situazione, da questa soglia scaturisce il “grido” e la “protesta”, che nei salmi incontriamo spesso, come particolare genere letterario, un modo insolito di rivolgersi a Dio. Il Salmo 39, nel contesto del salterio, colloca la fragilità dell’orante nella traiettoria storica salvifica e sapienziale. La fragilità, infatti, si trova riconosciuta da un “osservatorio creativo”, da un punto di vista insperato e in grado di aprire il cuore e la mente verso percorsi imprevedibili di luce.
di Gianattilio BonifacioFull Text
Abstract
The redeemed frailty
Marco gives to the character of Pietro large prominence and guarantees him an important communicative role in the Second Gospel. With James, John and Andrew and as spokesman of the Twelve Apostles, he becomes more important both than the biggest group and the smaller one. As the story goes on, Jesus himself, interacting with Pietro, progressively shapes the character who becomes for the readers the reference disciple figure. We find this narrative device in the Passion Stories too and right here it achieves its best expressive power. The comparison between the Jesus’ firmness and the Pietro’s conceited poltroonery unforgiving deconstructs the character. Only the risen Christ will be able to reconstruct him in his disciple and group spokesmen identity. Pietro becomes the “first” because, actually, it was the “last”.
Sommario
Marco riserva ampio rilievo al personaggio di Pietro e gli garantisce un importante ruolo nell’impianto comunicativo del II vangelo. In quanto portavoce dei Dodici/discepoli, egli viene spesso messo in risalto sia rispetto al gruppo più ampio, sia rispetto a quello più ristretto, con Giacomo, Giovanni e Andrea. Mano a mano che si dipana il racconto, Gesù stesso, interagendo con Pietro, ne modella progressivamente il personaggio che così diventa – per il lettore – la figura discepolare di riferimento. Questo dispositivo narrativo non viene meno nei racconti della Passione. Anzi proprio lì raggiunge la sua massima forza espressiva. Il confronto tra la fermezza di Gesù e la boriosa pavidità di Pietro ne decostruisce impietosamente il personaggio. Solo il Risorto lo saprà ricostruire nella sua identità di discepolo e portavoce del gruppo. Pietro viene costituito come il “primo”, perché, fino in fondo, è stato “ultimo”.
di Giovanni GirardiFull Text
Abstract
He has known and succored our frailty
Where does Jesus stand on the human frailty? Did he personally know and experience our frailty? To what extent and in which aspects did he share this dimension of our existence? How much was God involved with the human experience of his Son? These are the main questions in the Christological survey about the frailty theme (intended as vulnerability and fallibility). An in-depth study allows us to highlight the singularity of Jesus Christ with a real sharing of the human condition («in all things except sin»), while it personally exposes him to the experience of human weakness, gives to him an efficient salvific action, by virtue of the Spirit, that reveals the unprecedented «Almighty» Father’s face in the figure of the faithful in love «Abba», who unleashes its power in the in the Crucified and Risen’s weakness. And so begins a prospective of reasonable hope for the believer, who experiences its own weakness and fragility, while drawing on the Spirit’s resource.
Sommario
Come si è posto Gesù di fronte alla fragilità umana? Ha personalmente conosciuto e sperimentato la nostra fragilità? Fino a che punto e in quali aspetti ha condiviso questa dimensione della nostra esistenza? In che misura Dio si è implicato nell’esperienza umana del suo Figlio? Sono gli interrogativi guida del sondaggio cristologico effettuato in riferimento alla tematica della fragilità (come vulnerabilità e come fallibilità). La ricognizione consente di evidenziare che la singolarità di Gesù Cristo unita alla condivisione reale della condizione umana («in ogni cosa… escluso il peccato»), mentre lo espone personalmente all’esperienza della debolezza umana, gli consente un’efficace azione salvifica, in forza dello Spirito, che rivela il volto inedito del «Dio Padre onnipotente» nella figura dell’«Abbà» fedele nell’amore, che dispiega la sua potenza nella debolezza del Crocifisso-Risorto. Si apre così una prospettiva di sensata speranza per il credente, che ancora sperimenta la propria debolezza e la fragilità mentre attinge alla risorsa dello Spirito.
di Giuseppe LaitiFull Text
Abstract
Living the fragility according to Christian Faith
The text tries to stretch a wire between the anthropological side, the Christological centre, the ecclesial space and the Christian experience relative to the fact/experience of frailty. At the same time the frailty appears both as condition of human existence, exposed to the vulnerability, and as spiritual category, underlying attitude towards life. Frailty is our limit condition, but it can also become an original and personal way of interpreting and living it. The Easter event of Jesus reveals, exactly from within the passion to whom frailty exposes, the wealth that it can give as gratuitousness and of love’s fidelity. Hence comes to life the condition of the Christian faith in the world and takes a shape the believer’s knowledge as art of interpreting and living the existence’s frailty it meets. The broken bread in the Eucharist as way of the Risen Lord among us presence celebrates our existence possibilities, even within our own fallibility. It says the hope of faith as the practice of charity.
Sommario
L’intervento si propone di tendere un filo tra il versante antropologico, il centro cristologico e lo spazio ecclesiale e del vissuto cristiano relativamente al dato/esperienza della fragilità. La fragilità si presenta ad un tempo come condizione dell’esistenza umana, esposta alla vulnerabilità, e categoria spirituale, atteggiamento di fondo di fronte alla vita. Fragilità è la nostra condizione di limite, ma può anche divenire modo personale originale di interpretarla e viverla. L’evento pasquale di Gesù rivela, proprio dall’interno della passione a cui la fragilità espone, la ricchezza che essa è suscettibile di portare come gratuità e fedeltà dell’amore. Di qui trae luce sia la condizione della fede cristiana nel mondo in quanto cammino mai concluso, sia prende forma la sapienza del credente come arte di interpretare e vivere le fragilità dell’esistenza che incontra. Il pane spezzato dell’eucaristia come modo della presenza del Signore risorto tra noi celebra le possibilità della nostra esistenza pur dentro le nostre fallibilità. Esso dice la speranza della fede come pratica della carità.
di Ezio FalavegnaFull Text
Abstract
Prepare for change
The article proposes an eminently pastoral reading of the presbyteral experience emerged during the Synod celebrated in Verona in 2002-2005. Inside the ecclesial community the attention and the significance of the priestly ministry emerge around it’s pastoral configuration. In particular it comes to light how ecclesial inconveniences difficulties surface but also elements to “encompass” the priest figure in relation to the own human experience, with Jesus Crist and the service of the Annunciation in and with the community. The last part of the article outlines the ministerial profile the presbyter is called upon to assume and that is summarized in a path on four guidelines: the discipleship as a cure of the presbyteral identity; the sinodality as a way to being in the ministry: the companionship as harmony with history; the “extrovert and solidarity-based” testimony as a concern for the mission.
Sommario
L’articolo propone una lettura eminentemente pastorale del vissuto presbiterale emerso durante il Sinodo celebrato a Verona negli anni 2002-2005. Vi emergono l’attenzione e la significatività del ministero presbiterale dentro la comunità ecclesiale, attorno alla sua configurazione pastorale. In particolare, viene messo in luce come affiorino disagi e fatiche ecclesiali, ma anche elementi per “ricomprendere” la figura del prete in relazione al proprio vissuto umano, con Gesù Cristo e con il servizio di annuncio nella e con la comunità. L’ultima parte dell’articolo delinea il profilo ministeriale che il presbitero è chiamato ad assumere e che è sintetizzabile in un percorso su quattro linee guida: il discepolato come cura dell’identità presbiterale; la sinodalità come modo di stare nel ministero; la compagnia come sintonia con la storia; la testimonianza “estroversa e solidale” come sollecitudine per la missione.
Numeri precedentiVedi tutti

Salvati per Gesù, morto e risorto
Vai al sommario

Divenire Chiesa: soggetti e comunità
Vai al sommario

La Parola di Dio nelle parole umane. Contributi degli studenti
Vai al sommario

Ascoltare e proporre il Vangelo con i giovani
Vai al sommario