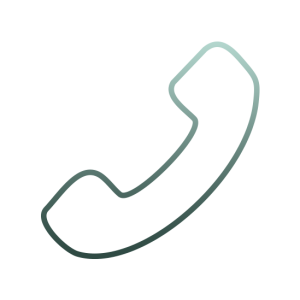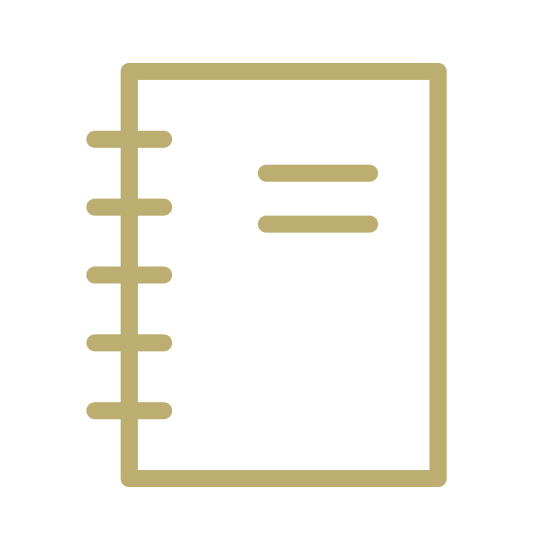
Numero 21
Il Vaticano II e la sua recezione
Luglio - Dicembre 2005
Abstract e allegati
di Andrea GainoFull Text
Vuole essere anche questo nostro studio un contributo a mantenere viva l’attenzione su un dono grande dello Spirito e a impegnare le nostre risorse affinché venga custodito e possa portare frutto per la chiesa e in senso più ampio per l’uomo d’oggi. Quanto infatti lo Spirito ha suggerito attraverso il Concilio resta come patrimonio per l’umanità intera come ebbe bene a sottolineare Paolo VI nel suo discorso a conclusione di quell’assise, discorso che rievoca in modo chiaro ed emblematico l’intenzione che accompagnò i padri conciliari nei loro lavori e il frutto che lo Spirito seppe trarre da quell’impegno: «tutta questa ricchezza dottrinale è rivolta in un’unica direzione: servire l’uomo. L’uomo, diciamo, in ogni sua condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua necessità. La Chiesa si è quasi dichiarata l’ancella dell’umanità, proprio nel momento in cui maggiore splendore e maggiore vigore hanno assunto, mediante la solennità conciliare, sia il suo magistero ecclesiastico, sia il suo pastorale governo […] Ma chi bene osserva questo prevalente interesse del Concilio per i valori umani e temporali non può negare che tale interesse è dovuto al carattere pastorale, che il Concilio ha scelto quasi programma, e dovrà riconoscere che quello stesso interesse non è mai disgiunto dall’interesse religioso più autentico, sia per la carità, che unicamente lo ispira (e dove è la carità, ivi è Dio!), e sia per il collegamento, dal Concilio sempre affermato e promosso, dei valori umani e temporali, con quelli propriamente spirituali, religiosi ed eterni: sull’uomo e sulla terra si piega, ma al regno di Dio si solleva».
di Giacomo CanobbioFull Text
Numeri precedentiVedi tutti

Salvati per Gesù, morto e risorto
Vai al sommario

Divenire Chiesa: soggetti e comunità
Vai al sommario

La Parola di Dio nelle parole umane. Contributi degli studenti
Vai al sommario

Ascoltare e proporre il Vangelo con i giovani
Vai al sommario