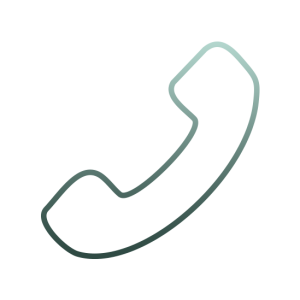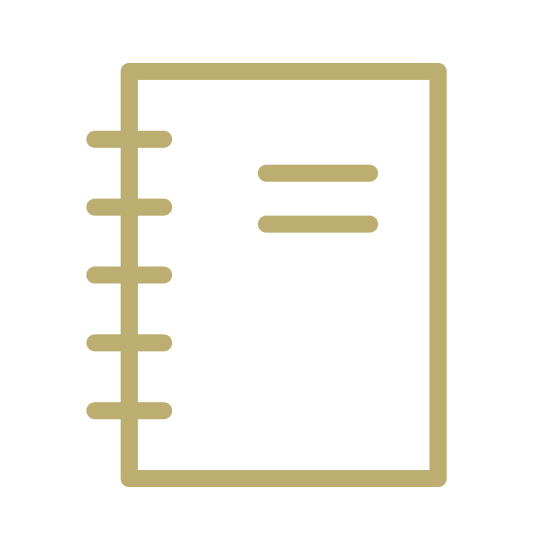
Numero 20
La domenica, giorno della festa
Giugno - Gennaio 2005
Abstract e allegati
di Andrea GainoFull Text
La ragione che porta a ripensare sempre e ancora come può essere vissuta la festa nel suo intreccio con la celebrazione del mistero cristiano, sta nel fatto di riconoscere l’ineludibile desiderio umano di celebrare, di dare cioè risalto a ciò che rende bella e attraente la vita evidenziando quegli eventi che più di altri hanno la capacità di mettere in risalto questa qualità del vivere umano. Così, attraverso la forza del linguaggio simbolico, la festa cerca di aprire il quotidiano, nella sua parzialità e frammentarietà, a dimensioni ulteriori dove bellezza e gratuità si possano percepire nella loro pienezza. Proprio a questo fa riferimento lo specifico cristiano che riconosce nell’evento di Gesù Cristo, a partire dalla passione morte e risurrezione, la capacità di dare qualità nuova al tempo dell’uomo, immettendo in esso la pienezza della grazia e così della festa. «In questa prospettiva di fede, la domenica cristiana è un autentico “far festa”, un giorno da Dio donato all’uomo per la sua piena crescita umana e spirituale» (Dies Domini, 58).
di Giuseppe LaitiFull Text
di Giuseppe AccordiniFull Text
di Martino SignorettoFull Text
di Giuseppe LaitiFull Text
di Cristina SimonelliFull Text
Numeri precedentiVedi tutti

Salvati per Gesù, morto e risorto
Vai al sommario

Divenire Chiesa: soggetti e comunità
Vai al sommario

La Parola di Dio nelle parole umane. Contributi degli studenti
Vai al sommario

Ascoltare e proporre il Vangelo con i giovani
Vai al sommario